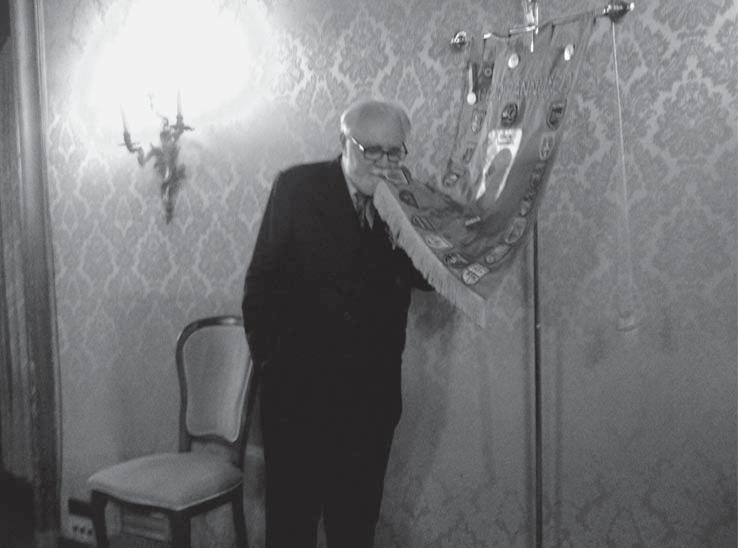Enzo Pezzati
l’impegno per la laicità dello stato
Ho conosciuto Pier Franco Quaglieni in una piccola tipografia di Moncalieri, alla periferia di Torino, nell’anno in cui il Centro “Pannunzio” iniziava la sua battaglia laica. Era il 1968. Egli aveva poco più di vent’anni e io ne avevo già cinquanta. “Il Mondo” di Pannunzio aveva cessato da poco la sua quasi ventennale esistenza.
Come fossimo vecchi amici, Quaglieni mi raccontò di un suo felice incontro con Arrigo Olivetti, che era stato l’Editore de “Il Mondo” e che aveva consentito l’istituzione del Centro “Pannunzio”, chiarendomi subito che l’ispirazione pannunziana del Centro non doveva essere interpretata come un richiamo sterilmente ripetitivo al fecondo connubio fra Croce, Einaudi e Salvemini, che Mario Pannunzio aveva realizzato nel suo settimanale, impegnandovi la collaborazione di Salvatorelli e Garosci, Spadolini e Gorresio, Adelfi e Cajumi, Galante Garrone e Antonicelli, Bobbio e Venturi e di decine e decine di altri rappresentanti della cultura laica.
Nella piccola tipografia di Moncalieri, Quaglieni curava la stampa della rivista “La Ronda” di cui era direttore; io invece vi mettevo piede per la prima volta per concordare la pubblicazione di un mio saggio sui Patti del Laterano, con annessi i testi integrali. La mia iniziativa piacque al giovane Quaglieni che, proprio in quei giorni, si era incontrato con amici del mondo della scuola per discutere, alla luce di alcuni scritti sulla Costituzione di Piero Calamandrei, della vexata quaestio dell’articolo 7, votato da Togliatti e dai suoi in favore della canonizzazione dei Patti del Laterano; e dall’incontro era uscito con la convinzione che la loro ignoranza era diffusa sia fra gli studenti sia fra gli insegnanti. Gli accennai al titolo che intendevo dare a quel mio saggio, un titolo provocatorio nei tempi che correvano di conformismo dilagante e di arroganze culturali: Mussolini, l’ultimo laico. Con discrezione Quaglieni mi suggerì di aggiungere un bel punto interrogativo. Certamente il punto interrogativo mi avrebbe sottratto, almeno in parte, alla facile ironia dei benpensanti che avevano tuonato e scritto per anni contro la vergogna del Concordato del ’29 e poi avevano compattamente votato per il suo integrale inserimento nel testo costituzionale. Ma non insistette quando gli mostrai il sottotitolo di copertina, che più che un chiarimento era una staffilata: “L’uomo che sottoscrisse i Patti Lateranensi appare, oggi, al cospetto di una classe dirigente insensibile ai problemi della laicità dello Stato, un alfiere intemerato dell’autonomia del potere civile”.
Di Mussolini, l’ultimo laico Quaglieni scrisse la presentazione fugando ogni possibile equivoca interpretazione: “Il titolo non induca in errore. Nell’intenzione dell’autore esso è una sfida polemica ad una classe politica di estrazione laica che avrebbe dovuto difendere la Repubblica laica, così com’è delineata nella Costituzione, ed invece si è impantanata negli equivoci degli opportunismi elettorali con la speranza fallace di ricavarne voti in campo cattolico. È una sfida ad una classe dirigente che ha dimenticato il suo dovere di respingere il Concordato, nato dall’incontro di due poteri egualmente intolleranti e autoritari: il governo di Mussolini e il pontificato di Pio XI”. E concludeva: “Un laico sui generis certamente Mussolini. Un laico che diede il colpo di grazia alla repubblica democratica di Spagna in nome della civiltà cattolica e latina ...; un laico, in qualche modo e in qualche misura, che, per certe sue posizioni di fermezza nei confronti della Chiesa, in pieno contrasto con quanto aveva sottoscritto col Concordato, si rivelò più deciso ed energico, nel far sentire la sua voce Oltretevere, della classe dirigente antifascista”.
Mussolini, l’ultimo laico approdò, subito dopo la pubblicazione, al Centro “Pannunzio” per il dibattito, che ebbe larga eco nella stampa e successo di pubblico.
Esaurita nel breve volgere di tempo l’edizione, Quaglieni me ne propose la ristampa con un breve titolo, non meno provocatorio e irriverente, Il Concordato da stracciare, in scoperta polemica contro quanti discettavano di una sua revisione, che arriverà in porto, con ulteriori mortificazioni dell’autonomia del potere civile, nel 1984, sotto gli auspici del partito socialista che, nel 1947, aveva salvato il suo onore politico e le residue speranze di una riscossa laica votando contro la canonizzazione dei Patti del Laterano.
Anche questa volta Pier Franco Quaglieni dettò la presentazione richiamandosi all’autorità di Benedetto Croce che, in sede di ratifica nel maggio del ’29, parlando a nome di una mezza dozzina di colleghi, aveva ammonito che il problema dei Patti del Laterano non si poteva risolvere col dire che Parigi val bene una messa, perché era problema di coscienza. Ma Croce aveva profetato ispirandosi al passato: “È certo che la Chiesa per effetto della legge varata dopo la presa di Roma non solo poté svolgere la sua opera e la sua propaganda, ma ottenne una considerazione di rispetto, e anche di reverenza, che le era venuta meno in Italia per secoli presso i migliori. Una sola prova, fulgida, vi addurrò a conferma del mio detto: la letteratura italiana, la quale da Dante a Foscolo, e anzi fino al Carducci della prima epoca, è tutta, nella lirica e nell’oratoria, nella satira e nella commedia, di accenti anticlericali, spesso feroci e sarcastici. Orbene questi accenti si spensero del tutto nella letteratura della nuova Italia [...]. Consapevoli del passato, solleciti dell’avvenire, noi guardiamo con dolore alla rottura dell’equilibrio che si era stabilito [...]. Ricominceranno spasimanti e sterili lotte su fatti irrevocabili, e pressioni, e minacce, e paure, e i veleni versati nelle anime dalle pressioni, dalle minacce e dalle paure”.
Intanto nel Paese ardeva la battaglia per il divorzio. Non era un problema di libertà di coscienza, bensì di autentica libertà civile. Pier Franco Quaglieni aprì il Centro “Pannunzio” al pubblico dibattito che ebbe larga risonanza per la severità della conduzione e degli interventi. E fu al termine di uno di quei dibattiti, a cui erano intervenuti i presentatori del progetto di legge, Baslini e Fortuna, conclusosi al ristorante caro a Cavour, in Piazza Carignano, per raccogliere fondi in favore delle forze divorziste, che Quaglieni mi propose di dedicare un volume alle testimonianze su Pannunzio e “Il Mondo”. Fui d’accordo e gli misi a disposizione la mia piccola casa editrice. Nell’arco di pochi giorni ammassò sulla mia scrivania gli articoli di storici, giornalisti, letterati, politici: Montanelli, Libonati, Carandini, Benedetti, La Malfa, Gorresio, Ruffini, Scalfari, Valiani, Bartoli, Elena Croce, Talarico, Jemolo, Rossi, Garosci, Cattani, Barolini, Barzini, Compagna, Tobino, Spera, Ajello, Battaglia, Ferrara, Gatti, Romeo, Russo, Ungari, Virdia. Il giorno dopo mi consegnò un suo bozzetto di Pannunzio per la copertina. Impaginato da Giulio Castelli, il libro Pannunzio e “Il Mondo” vide la luce nell’arco di un mese. Pier Franco Quaglieni ne scrisse la nota introduttiva: un gioiello di giornalismo e di letteratura, che pubblicherei integralmente se lo spazio me lo consentisse.
Da venticinque anni vivo lontano da Torino, in una piccola città di provincia che nel raggio di un centinaio di chilometri ha per confine Paestum e Velia (l’antica Elea di Parmenide e di Zenone), Sibari, Crotone, Locri, Metaponto.
Non ho mai perduto i contatti con Pier Franco Quaglieni. Con i suoi articoli ha dato lustro a una mia rivista e reso famoso il Centro “Pannunzio” di Torino fra la gente di questo Mezzogiorno dei Vico e dei Telesio, dei Campanella e dei Fortunato, dei Salvemini e dei Compagna.